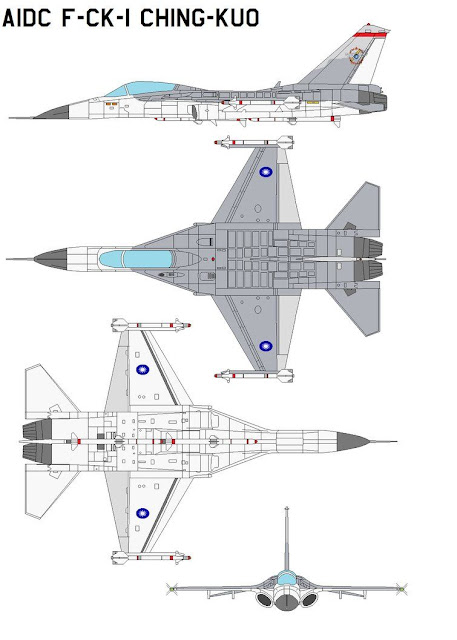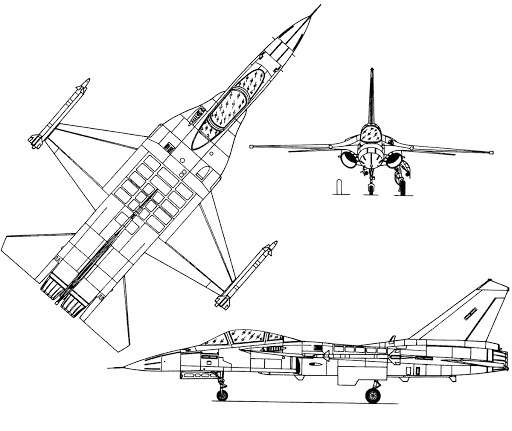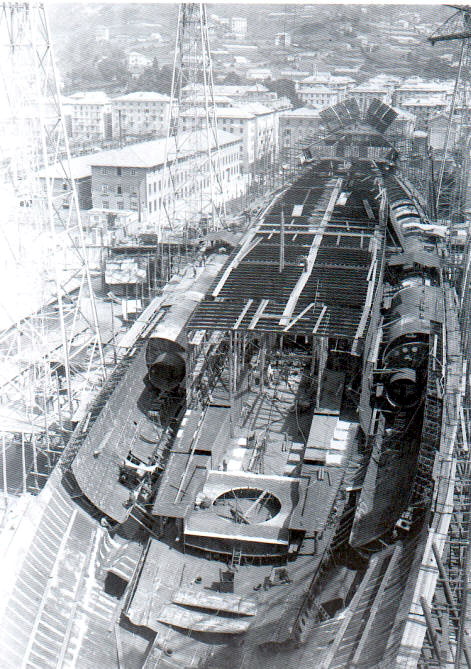Il AIDC Ching Kuo (經國號戰機) è un caccia da superiorità aerea con capacità multiruolo bimotore biposto prodotto in collaborazione tra Taiwan e gli USA. Il progetto sviluppato fin dagli anni ottanta si è concretizzato in un prototipo nel 1989 e nell'ingresso in linea nella forza aerea di Taiwan nel 1994. Il Ching Kuo è tuttora in servizio.
Sviluppo
Sviluppato per sostituire gli F-5 e gli F-104, il Ching Kuo assomiglia ad un incrocio tra un F-16 e un F-18.
Inizialmente, la forza aerea di Taiwan era interessata all'acquisizione dell F-20 Tigershark, ma l'iniziativa venne bloccata nel 1982 a causa della decisione del governo statunitense di non esportare il nuovo caccia nello stato insulare per evitare l'incrinarsi dei rapporti con la Repubblica Popolare Cinese. In virtù di questa decisione il governo di Taiwan si rivolse alla francese Dassault e concordò con essa l'acquisto del Dassault Mirage 2000.Nonostante ciò, gli Stati Uniti autorizzarono le proprie industrie aeronautiche a collaborare con quelle taiwanesi per lo sviluppo congiunto di un nuovo velivolo da caccia.
Il primo volo si ebbe nel 1989. Dalla versione biposto da combattimento venne derivata anche una versione da addestramento.
Erano inizialmente previsti 250 esemplari, ma a causa dell'insoddisfazione generale della ROCAF, la produzione venne arrestata al 130° modello. Sono stati invece acquisiti diversi F-16 e Mirage 2000.
Tecnica
Il velivolo è stato concepito per fungere da caccia leggero da difesa aerea a corto raggio. Ciò ha portato i tecnici a concentrarsi sulla maneggevolezza e non sui parametri di autonomia e velocità.
Inizialmente l'armamento del velivolo era stato pensato per il solo combattimento aria-aria, ma successivamente, parallelamente all'aereo Taiwan ha sviluppato anche alcuni appositi sistemi d'arma come i missili antinave Hsiung Feng II del tipo sea skimming, che volano a pelo dell'acqua.
Il Ching Kuo è armato con un cannone M61 da 20 mm, missili Sidewinder, Sky Sword I e II, bombe a guida laser GBU-12, missili aria-superficie Maverick e i già citati missili antinave.
Nel 2001 Taiwan ha avviato un programma di aggiornamento dei Ching Kuo allo standard F-CK-1C/D: 70 esemplari saranno potenziati con notevoli miglioramenti in fatto di avionica e armamento, oltre a disporre di maggior carburante interno.
Versioni:
- F-CK-1 A/B Ching-kuo (135)
- prototipi (4)
- F-CK-1A - monoposto (103)
- F-CK-1B - biposto (28)
- F-CK-1 C/D Hsiang Sheng
- prototipi (2)
- F-CK-1C - monoposto
- F-CK-1D - biposto
Utilizzatori:
- Taiwan - Zhonghua Minguo Kongjun - Dei 130 esemplari consegnati tra il 1993 ed il 2000, 127 aerei sono stati aggiornati come F-CK-1C e F-CK-1D e gli aggiornamenti interessano sia l'avionica che l'armamento. Al gennaio 2018 risultano in carico 127 esemplari. All'ottobre 2018, sono 129 gli aerei aggiornati, in quanto anche i due prototipi usati per il programma sono stati consegnati all'aeronautica.
ENGLISH
The AIDC F-CK-1 Ching-Kuo (Chinese: 經國號戰機; pinyin: Jīngguó Hào Zhànjī), commonly known as the Indigenous Defense Fighter (IDF), is a multirole combat aircraft named after Chiang Ching-kuo, the late President of the Republic of China. The aircraft made its first flight in 1989. It was delivered to the Republic of China Air Force (Taiwan) in January 1994 and entered service in 1997. All 130 production aircraft were manufactured by 1999.
Taiwan initiated the IDF program when the United States refused to sell them F-20 Tigershark and F-16 Fighting Falcon jet fighters following diplomatic pressure from China. Taiwan therefore decided to develop an advanced indigenous jet fighter. The Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC), based in Taichung, Taiwan, designed and built the IDF jet fighter.
Development
Background
The preliminary search for a replacement for the ROCAF's F-5s and F-104s began with the XF-6 indigenous fighter project, later renamed Yin Yang, in the late 1970s. After the US established formal relations with China and ended the Mutual Defense Treaty with Taiwan, President Chiang Ching-Kuo decided to expand the indigenous defense industry and on August 28, 1980, ordered AIDC to design an indigenous interceptor. Originally, the ROCAF listed the priority of the XF-6 behind the XA-3 Lei Ming single seat attack aircraft, due to the believed high risks of the XF-6 project.
The signing of the 1982 US-China Joint Communiqué limited arms sales to Taiwan. The United States refused to sell the General Dynamics F-16 Fighting Falcon and the Northrop F-20 Tigershark (which had been developed largely to meet Taiwanese national defense needs for an advanced jet fighter to replace their older F-5 jet fighters) thereby ensuring the continuation of the indigenous fighter project. Although US President Ronald Reagan reluctantly accepted his advisers' suggestion of building relations with China to counter the USSR, Reagan decided to balance the 1982 US-PRC Communiqué with the "Six Assurances" to Taiwan. This opened the door for US technology transfer and assistance to Taiwan's defense industry, including the IDF project.
Design phase
The AIDC officially began the IDF development project in May 1982 following the ROCAF's failure to purchase new fighters from the United States as a result of Chinese diplomatic pressure. The project was named An Hsiang (安翔):Safe Flight) and divided into four sections in 1983:
- Yin-Yang (鷹揚): "Soaring Eagle". Development of the airframe. Some cooperation with General Dynamics.
- Yun-Han (雲漢): "Cloud Man". Development of the aircraft powerplant and propulsion. Cooperation with Garrett (Now Honeywell).
- Tien-Lei (天雷): "Sky Thunder". Development of the avionics systems. Some cooperation with Smiths Industries, with some components purchased directly from Lear Astronics (today a subsidiary of BAE), Litton (today a subsidiary of Northrop Grumman) and Martin-Baker.
- Tien-Chien (天劍): "Sky Sword". Development of air-to-air missiles.
In April 1997 American company Litton's Applied Technology division was awarded a production contract and options totaling $116.2 million by the Aerospace Industrial Development Corporation for Improved Radar Warning Receivers (IRWR) to be installed aboard.
Yun Han: engine research
Exports of advanced engines such as the General Electric F404 or the Pratt & Whitney F100 were not available to Taiwan and both the General Electric J85 and General Electric J79 were considered unsuitable in their performance, and most European and American engine companies declined to cooperate with the project. Joint investment with Garrett became the only practical solution.
In 1978, following the success of the TFE731 engine, U.S. engine company Garrett announced joint research of the TFE1042 afterburner with the Swedish company Volvo Flygmotor. The TFE731 Model 1042 was touted as a low bypass ratio "military derivative of the proven commercial TFE731 engine" and that it would provide "efficient, reliable, cost effective propulsion for the next generation of light strike and advanced trainer aircraft", with a thrust of 4260 lbf (18.9 kN) dry and 6790 lbf (30.2 kN) with afterburner. After the initial negotiation, the investment was going to be divided between Garrett, Volvo, AIDC, and the Italian company Piaggio. The development would consist of the non-afterburning TFE1042-6 for light attack aircraft and advanced trainers, and the TFE1042-7 for the AMX or the F-5 upgrade. AIDC also suggested upgrading the TFE1042-7 to 8,000 lbf (36 kN) thrust in a twin-engine installation, in order to compete with the GE F404. However, the JAS 39 Gripen project decided to continue with a single F404, and Piaggio asked to participate at a later date due to financial concerns.
ITEC completely redesigned the TFE1042-7 into the TFE1042-70 – for example, the bypass ratio was changed from 0.84 to 0.4, and the investment had increased from US$180 million to about US$320 million. However, to avoid pressures from China, the US government had asked all American companies cooperating with the Taiwan on the IDF project to remain low-key. Therefore, the perception that "the TFE1042 is merely the civilian engine TFE731 with an afterburner" was never completely dispelled.
In 1985, the preliminary review of the IDF's design revealed some performance requirement shortfalls, and it was determined that an upgrade of engine thrust by 10% was the simplest solution. Due to American export license restrictions, ITEC used FADEC to artificially limit the thrust below a certain altitude (the restriction was not removed until 1990). Although the upgrade essentially used the TFE1088-11 configuration, to reduce political interference ITEC renamed the original, lower-thrust version as the TFE1042-X70 and retained the TFE1042-70 designation for the upgraded version.
In 1988, ITEC decided to invest in the 12,000 lbf (53 kN) thrust TFE1088-12, which was re-designated as the TFE1042-70A for political reason as well. Preliminary studies had shown that the IDF could supercruise with the new engine. At the same time, General Electric Aviation decided to enter the market with the J101/SF, a smaller version of the F404. However, after the IDF order was cut in half due to budget concerns, the TFE1088-12 engine upgrade plan ended as well.
Yin Yang: aerodynamic design
The cooperation between AIDC and General Dynamics (GD) was divided into four phases:
GD analyzed the ROCAF's aircraft performance and force requirements.
Taiwan assessed GD's reports and chose between AIDC's original design and GD's new design.
AIDC sent personnel to GD for the preliminary design phase.
GD sent personnel to Taiwan to complete the project.
GD's assistance was restricted by the US State Department's arms export control, which limited GD's work to initial design consulting but not further development, production, or marketing.
Many different airframe design concepts were explored (e.g. the 2D Thrust-Vectoring nozzle of XX-201, the double delta wings/twin tailed 401). After the General Electric J79 was officially abandoned as the potential engine solution in 1983, three configurations emerged from AIDC.
Configuration A was similar to the F-5E.
Configuration B was similar to the Eurofighter Typhoon and Saab Gripen.
Configuration C was similar to the F-15.
At the same time, GD worked on the G configuration in parallel. Eventually the G-4 was selected, but with many features of the C-2 integrated. During this time, the project was named the "Light Weight Defense Fighter". In 1985, the configuration conceptual design had evolved into the SE-1 preliminary design. By the end of 1985, AIDC decided to skip the prototype stage and go into Full Scale Development (FSD) directly, in order to reduce time and save money. The project was again renamed into the "Indigenous Defense Fighter". Four FSD aircraft were made, with three single-seaters and one double-seater.
Tien Lei: Avionics Integration
The IDF is equipped with a GD-53 Golden Dragon multi-mode monopulse pulse-Doppler radar, which is based on the General Electric AN/APG-67 X band radar developed for the F-20 while sharing some components and technologies of the AN/APG-66 radar of the F-16A, and using a larger antenna than used by the F-20. and this adaptation resulted in the look-down and shoot-down capability of GD-53 being greatly enhanced in comparison to that of the original AN/APG-67, reaching that of the AN/APG-66. The radar can simultaneously track 10 targets and engage two of the 10 targets tracked with TC-2 active radar seeker BVRAAMs.
The design is inherently unstable in pitch, so the IDF incorporated a modern triple-redundant full authority fly-by-wire control system. The avionics suite was based on modular architecture with dual redundant MIL-STD-1553B digital databuses. The Honeywell H423 inertial navigation system, the TWS-95 RHAWS, and the Bendix-King head-up display were selected. Some capabilities may have been delayed or dropped in order to meet the performance requirement, since the engine limitation has resulted in the necessity of strict weight control.
Tien Chien: Missile R&D
The CSIST's Tien Chien (Sky Sword) project was slightly more independent, since it was considered to be a development for all the ROCAF's aircraft rather than only the IDF. The Tien Chien 1 (TC-1) is a short range infrared-seeking missile with an external configuration similar to that of the AIM-9 Sidewinder, while the Tien Chien 2 (TC-2) is an active radar homing Beyond Visual Range missile.
The first test firing of the TC-1 missile was performed by an F-5E in April 1986, with the Beech target drone successfully destroyed. Initial production of the TC-1 began in 1989, and it entered service in 1991. Both the AIM-9 and the TC-1 have been seen in use on operational IDFs.
CSIST is believed to have cooperated with Motorola and Raytheon on the TC-2's active seeker, which is believed to be based on their seeker design which was proposed for the AIM-120. 40 pre-production TC-2 missiles were produced before 1995, and were the only BVR AAMs that the ROCAF had in its inventory during the 1995–96 Taiwan Strait Missile Crisis. Over 200 production TC-2s were originally planned.
Upgrades
During the F-CK-1’s development it was tapped as the secondary delivery vehicle for the Taiwanese nuclear weapons then in development. The primary delivery method was to be the Sky Horse missile. Weapons designers at CSIST were instructed to design the nuclear weapon to fit within the dimensions of the F-CK-1’s centerline drop tank (~50cm diameter). Modifications to the aircraft would have been required for it to obtain the desired 1,000km range (especially without the centerline drop tank available) and were envisioned to include more efficient non-afterburning engines. The F-CK-1 would not have been able to fulfill the nuclear strike mission until mid-1989 at the very earliest. Early designs called for an unpowered gravity bomb. The nuclear weapons program was shut down under US pressure before the F-CK-1 entered service and the dedicated nuclear strike variant was never produced.
The first stage of upgrades to the fleet was originally planned to be completed by 2013, and was planned to include improved avionics, radar, electronics, weapons capabilities and lifespan extensions. In May 2014, the ROC Air Force made photos of the fighters with enhanced Wan Chien long-range missile capabilities public. The upgrade program was finally completed in 2018.
Variants
F-CK-1 A/B Ching-Kuo
The first successful test flight by FSD A1 was made on May 28, 1989. The first two-seater (and the fourth prototype), FSD B1, conducted its first flight on July 10, 1990. The first successful firing of the Tien-Chien II (Sky Sword II) air-to-air missile took place in 1992, with the ROCAF establishing its first F-CK-1 squadron the following year with a batch of 10 pre-production aircraft.
The ROCAF's initial order for 256 aircraft was cut to 130 in 1991, following deals for the purchase of 150 F-16 Block 20 A/B and 60 Mirage 2000-5Ei/Di with the US and France. The last IDF A/B rolled off the production line in 1999. Mid-life updates to the aircraft were initiated in 2011.
F-CK-1 C/D Hsiang Sheng
The Ministry of National Defense (MND) announced that beginning in 2001, the government would include a new budget allocation for the IDF upgrade plan (as included in the five MND proposals to help AIDC). The five proposals were:
Upgrades of the AT-3, IDF, and F-5 would be assigned to AIDC in the future.
The Army Utility Helicopter, the Navy's long range ASW aircraft, a helicopter for the Marines, and an Air Force medium transport will all be produced and assembled by qualifying domestic firms in conjunction with the foreign firms that originally designed them.
NCSIST and AIDC will jointly assemble a team for the early planning of the ROCAF's next generation fighter, in order to assess procurement methods and suggest concepts.
AIDC's joint ventures with foreign firms or alliances with domestic firms will be given high priority in military aircraft service and maintenance.
In the future, the military will give responsibility for weapons system flight tests, electronic warfare exercises, air towing drones, avionics maintenance, and weapons procurement planning to AIDC, in situations where AIDC has the professional capacity that the military lack. This is part of the seven-year IDF C/D R&D plan (FY2001~FY2007), which allocates 10 million New Taiwanese Dollars (NTD) annually for a total of 70 million NTD for both CSIST and AIDC. Initial media reports indicated that the upgraded IDF would be called the "Joint Countermeasure Platform".
In 2001, it was reported that development of a new "stealth" variant with more powerful engines and improved fire-control system would commence that year. In a 2006 interview with Jane's Defence Weekly, former AIDC Chairman Sun Tao-Yu said that two new prototypes had been manufactured. The upgrade would allow the IDF to carry an additional 771 kg of fuel. In addition, it includes an improved avionics suite, retrofitted electronic warfare capabilities, and new weapons systems. The landing gear has been strengthened to accommodate the additional payload and fuel, but the plan for a dielectric radar-absorbing "stealth" fuselage was dropped due to concerns over weight. The project consists of three phases:
Increase the carrying capacity for the TC-2 beyond-visual range air-to-air missile from two to four. Integrate the TC-2A anti-radiation missile and the Wan Chien cluster bomb. In addition, two conformal fuel tanks were seen on the two newly built prototype aircraft, these are not seen on production upgrades.
Upgrade the mission computers, the electronic counter-countermeasures, the electronic warfare systems, the Active Identification Friend or Foe (AIFF) system and the terrain-following radar.
Ground and air testing.
The development contract for the upgraded 32-bit IDF C/D flight control computer was awarded in 2002 to BAE Systems. AIDC said that the improvements of the flight computer will result in "a safer, higher-performing aircraft.” Other improvements made include enhanced electronic warfare capabilities, a strengthened landing gear and a digital anti-skid system. The upgrade also included new indigenous flight control software ending the reliance on US controlled source code.
The first test flight of the upgraded IDF was reportedly successfully completed a few days ahead of schedule in early October.
On March 27, 2007, President Chen Shui-Bian witnessed a test flight of F-CK-1D, and announced that the upgraded IDF will be named Hsiung Ying (Brave Hawk), which signifies that the new fighter would protect the homeland just like the Crested Goshawk.
As of 12/2009, 71 F-CK-1 A/B are upgrading to F-CK-1 C/D over 4 years span for over US$500 million, according to AIDC CEO, under Project Hsiang Chan (翔展), as AIDC and ROCAF had signed a contract for the expected upgrade program.
In 2018 AIDC delivered the last upgraded F-CK-1 C/D to the Republic of China Air Force.
IDF Lead-in Fighter Trainer
According to the media, the AIDC IDF trainer concept apparently involved the removal of the fire control radar and combat systems with the retention of rear-seat flight controls, so that the IDF could be used as a lead-in fighter trainer (LIFT). The ROCAF seemed to have reservations with the concept, however, as it would mean the IDF LIFT would not be usable in wartime. A MND letter said, "Regarding the newspaper report of AIDC's desire to use the IDF fighter as a basis for supersonic trainer development, it is only that company's operational planning concept. The Ministry of National Defense and the Air Force currently do not have such a plan". The letter then said that due to a tight budget allocation the ROCAF would instead ask AIDC to extend the life of the AT-3 and continue to use the F-5 in the LIFT role.
In 2003, the former AIDC Chairman Huang Jung-Te said that AIDC still hoped the ROCAF would consider using a simplified version of the IDF for LIFT, and that such a concept could have a cost as low as US$16 million per unit, compared to the T-50's 19 million. However, the F-CK-1 LIFT modifications or new production concepts never received government funding or approval.
In May 2006, Lt. General Cheng Shih-Yu testified that the MND indeed plans to retire the F-5E/F by 2010 and allow the in-service IDFs to take over training missions. It is unclear what modifications (if any) will be made to IDFs after they become trainers.
Operators:
- Taiwan - Republic of China (Taiwan) Air Force – 131 aircraft, including 6 pre-production aircraft.
Specifications (F-CK-1A)
General characteristics
- Crew: 1
- Length: 14.48 m (47 ft 6 in)
- Wingspan: 9 m (29 ft 6 in)
- Height: 4.42 m (14 ft 6 in)
- Wing area: 24.2 m2 (260 sq ft)
- Empty weight: 6,500 kg (14,330 lb)
- Gross weight: 9,072 kg (20,000 lb)
- Max takeoff weight: 9,526 kg (21,001 lb)
- Powerplant: 2 × Honeywell/ITEC F125-GA-100 turbofan, 27 kN (6,100 lbf) thrust each dry, 42.1 kN (9,500 lbf) with afterburner
Performance
- Maximum speed: Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h)
- Range: 1,100 km (680 mi, 590 nmi)
- Service ceiling: 16,800 m (55,100 ft)
- Thrust/weight: 1.01
Armament
- Guns: 1× 20 mm (0.787 in) M61A1 6-barreled Gatling cannon
- Missiles:
- 4× Sky Sword I
- 4× Sky Sword II
- 4× AIM-9 Sidewinder
- 4× AGM-65 Maverick air-to-surface missiles
- 2× Hsiung Feng II Anti-ship missiles
Bombs:
- 2x Wan Chien air-to-ground cruise missile
- 10x Mark 82 bomb
- 10x Mk-20 Rockeye II
- 3x Mark 84 bomb
Avionics
- Radar: 1× GD-53 X-band pulse doppler
- Effective scanning range:
- Look up: 57 kilometres (35 mi)
- Look down: 39 km (24 mi).
(Web, Google, Wikipedia, You Tube)